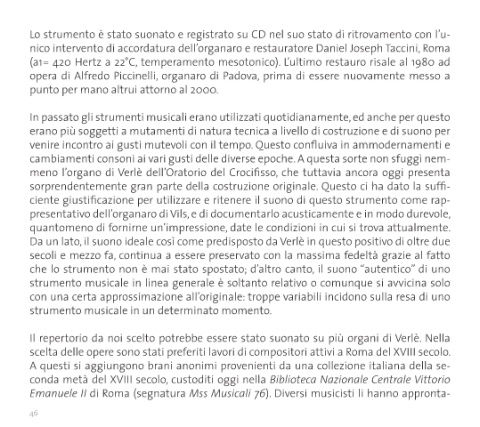Page 47 - Booklet
P. 47
Lo strumento è stato suonato e registrato su CD nel suo stato di ritrovamento con l’u- ti man mano, completandoli tuttavia secondo le esigenze personali. Per questo motivo
nico intervento di accordatura dell’organaro e restauratore Daniel Joseph Taccini, Roma questa fonte rappresenta un compendio o un vademecum per gli organisti dell’epoca e
(a1= 420 Hertz a 22°C, temperamento mesotonico). L’ultimo restauro risale al 1980 ad per noi uno specchio del repertorio ecclesiastico degli organisti del XVIII secolo. Inoltre,
opera di Alfredo Piccinelli, organaro di Padova, prima di essere nuovamente messo a è anche vicina ai bisogni di coloro che suonano strumenti a tastiera: contiene infatti
punto per mano altrui attorno al 2000. 181 composizioni in totale, tra cui repertori cantati, come messe, inni, antifone, oltre ad
arrangiamenti strumentali come versetti, pastorali, pezzi di carattere e pure danze, ad
In passato gli strumenti musicali erano utilizzati quotidianamente, ed anche per questo esempio l’allemanda, l’anglaise, la giga e numerosi minuetti. Nell’uso, tuttavia, è possi-
erano più soggetti a mutamenti di natura tecnica a livello di costruzione e di suono per bile che la musica profana e quella sacra si siano occasionalmente incrociate. Informa-
venire incontro ai gusti mutevoli con il tempo. Questo confluiva in ammodernamenti e zioni più dettagliate su questa fonte basilare per il nostro progetto, sono consultabili nel
cambiamenti consoni ai vari gusti delle diverse epoche. A questa sorte non sfuggì nem- RISM-OPAC (Répertoire Internationale des Sources Musicales/Repertorio Internazionale
meno l’organo di Verlè dell’Oratorio del Crocifisso, che tuttavia ancora oggi presenta delle Fonti Musicali - Online Access Public Catalogue), su internet sul sito www.rism.info
sorprendentemente gran parte della costruzione originale. Questo ci ha dato la suffi- (sigillo di biblioteca I-Rn).
ciente giustificazione per utilizzare e ritenere il suono di questo strumento come rap-
presentativo dell’organaro di Vils, e di documentarlo acusticamente e in modo durevole, Sia la Missa Beatae Mariae Virginis (Messa in onore della Beata Maria Vergine) sia la Missa
quantomeno di fornirne un’impressione, date le condizioni in cui si trova attualmente. in Dominicis et in Festis Simplicibus (Messa per la Domenica e Feste semplici) sono messe
Da un lato, il suono ideale così come predisposto da Verlè in questo positivo di oltre due alternatim. Nei movimenti dell’ordinario, musiche d’organo e canti del coro si alternano
secoli e mezzo fa, continua a essere preservato con la massima fedeltà grazie al fatto verso per verso. In entrambe le messe del manoscritto I-Rn Mss Musicali 76, la voce per i
che lo strumento non è mai stato spostato; d’altro canto, il suono “autentico” di uno passaggi solisti dell’organo è segnata come Partimento, precisamente i versi al posto di
strumento musicale in linea generale è soltanto relativo o comunque si avvicina solo un verso di testo nel Kyrie, nel Gloria, nel Sanctus e nell’Agnus Dei. Questo significa che
con una certa approssimazione all’originale: troppe variabili incidono sulla resa di uno qui è stata scritta solamente una voce di basso, ricca di figure e ritmicamente complessa,
strumento musicale in un determinato momento. talvolta con basso cifrato. Ciò costituisce comunque una sfida per l’organista, in quanto
egli deve provvedere personalmente alla creazione di una melodia e di un’armonia ade-
Il repertorio da noi scelto potrebbe essere stato suonato su più organi di Verlè. Nella guate per il movimento. Per la realizzazione di un Partimento sono necessarie fondate
scelta delle opere sono stati preferiti lavori di compositori attivi a Roma del XVIII secolo. nozioni di tecnica compositiva, nonché grande sensibilità artistica ed estetica, così da
A questi si aggiungono brani anonimi provenienti da una collezione italiana della se- poter ottenere un risultato musicale di qualità. Dato che l’interpretazione è estempora-
conda metà del XVIII secolo, custoditi oggi nella Biblioteca Nazionale Centrale Vittorio nea, alcune parti da ripetere possono variare nell’esecuzione. Coerentemente con gli usi
Emanuele II di Roma (segnatura Mss Musicali 76). Diversi musicisti li hanno appronta- del tempo, le melodie dei versi cantati sono sostenuti da una voce di basso omofonica,
46 47